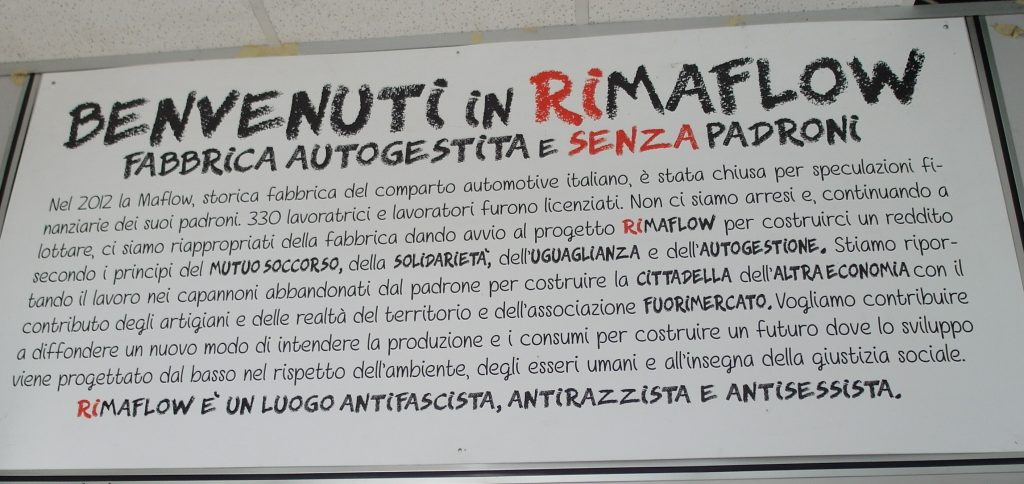(Pubblicato nel 2012 in inglese su Human Geography; rivisto il 28 ottobre 2023)
La forza dell’immaginazione e dell’imitazione: isole e derive culturali
L’immaginazione degli esseri umani è fervida e molto spesso si diventa ostaggio di essa.
Jim Giles in un articolo su New Scientist (tradotto da Internazionale del 23/29 luglio 2010, pp. 51-52), cita l’economista David Hirshleifer che nel 1993 ha scritto “più sentiamo o leggiamo una notizia e più la consideriamo vera”; “la forza delle immagini reiterate è tale da poterci indurre a considerare i messaggi che ci vengono imposti come la storia stessa, la pura e semplice realtà” (Augé, 2009, p.39). Il meccanismo mentale per cui si crede che quello che è pensato o ripetuto continuamente sia vero può essere analizzato e compreso a partire dal concetto di meme, “egoista” come il gene, elaborato da Richard Dawkins (1995). Il meme-idea è l’ “unità di trasmissione culturale o unità di imitazione” (ibid, p. 254), “una entità, il meme-idea, che è capace di essere trasmessa da un cervello all’altro” (ibid, p. 258) “l’imitazione, in senso lato, è il modo in cui i memi possono replicarsi” (ibid, p. 256).
In pratica un meme-idea è qualsiasi cosa che ci entra nella mente (e nella memoria), spesso senza che ce ne rendiamo conto, e che progressivamente si accumula per formare l’insieme delle nostre opinioni, convinzioni, valori, identità, percezioni, ecc. ecc.. Anche i nostri studi e le cose che impariamo (per nostra volontà o inconsapevolmente) si comportano come dei memi, e cioè tendono non solo a consolidarsi nella nostra mente, ma anche a replicarsi in altre menti grazie alla trasmissione (cosciente o no) che ne facciamo noi stessi con parole e azioni. Un video di youtube come il videoclip coreano Gangnam Style che viene visto, cliccato più di 2 miliardi di volte (al 31 maggio 2014) o un “hoax” (bufala, falso) che diventa “virale” sul web sono esempi contemporanei di memi di successo.
Possiamo considerare risultato di un insieme di memi il tifo sportivo e i conseguenti comportamenti, che vengono descritti come “passione” e così vengono quindi interpretati. La diffusione tra i tifosi di certi convincimenti (arbitraggi ostili, squadre “nemiche”, giudizi sui giocatori, comportamenti “giusti” dei tifosi, autostima, ecc.) sono il tipico risultato del gioco delle unità di imitazione e di trasmissione. Che è identico in tutte le dinamiche di gruppo, compreso l’ambito ideologico ed evidenti in quelle della politica, del nazionalismo, delle identità. Chi condivide gli stessi memi tende a costituire ciò che si può definire, riprendendo l’approccio di Luigi Luca Cavalli Sforza (2010), una isola culturale; che si cerca di preservare dai cambiamenti rafforzando la ripetizione (a parole, coi simboli e nei comportamenti) dei memi che vengono definiti “tradizioni” e/o “valori”. La finalità inconsciamente condivisa e profondamente umana è quella di proteggersi grazie alla solidarietà del gruppo in quanto “il ruolo primordiale della cultura è di assicurare l’esistenza del gruppo come gruppo, e dunque di sostituire l’organizzazione al caso” (Lèvi Strauss, 1978, p.75). L’antropologo Stefano Boni parla di una “omogeneità [che] si ottiene mediante meccanismi comunicativi minuti e quotidiani (il pettegolezzo e la lode, la smorfia e il sorriso, l’esclusione e l’accoglienza, la multa e il premio) che scoraggiano la devianza e incoraggiano il conformismo” (Boni, 2011, p.51).
Però, essendo essenzialmente una dinamica incontrollabile, anche se influenzabile, il meme innesca anche una deriva culturale che nel tempo può cambiare il significato e il senso delle parole perché “a prima vista sembra che i memi non siano per nulla dei replicatori ad alta fedeltà” dato che “i memi vengono trasmessi in forma alterata” (Dawkins, 1995, p.257). Il processo della deriva culturale è spesso così lento che i soggetti coinvolti difficilmente lo percepiscono e questo, a volte, porta alla paradossale convinzione che “sia sempre stato così” riferito a dinamiche, idee, comportamenti che in realtà sono il risultato di un cambiamento più o meno recente. E questa convinzione è fortemente presente nelle nuove generazioni, che non avendo esperienza diretta di come stavano le cose nel passato, tendono a pensare che la loro esperienza quotidiana sia “stabile” e tendenzialmente la stessa dovunque.
Per esempio, il termine rete indica da millenni uno strumento usato per imprigionare e spesso per uccidere chi o cosa è rimasto preso nella rete. Oggi “rete” (e “net”), riferito al sistema di collegamenti computerizzati, viene usato così tante volte nel senso di “libertà”, “movimento”, “interconnessione” che il significato originario è sfumato quasi del tutto se non scomparso per le nuovissime generazioni. Almeno nelle società “ricche” dove lo spazio (strade, case, cavi, immagini, computer, ecc.) è sempre più artificiale e virtuale. E dove i confini, mobili e invisibili, che gli esseri umani creano e/o subiscono nella vita quotidiana vengono ancor di più “nascosti” tramite il meccanismo di una vera e propria diversione, una distrazione di massa risultato sia di un tipo di sviluppo della comunicazione sia di una volontà politica nell’usarla strumentalmente per la creazione del consenso o per esercitare il potere.
Le isole culturali sono dunque costituite da un insieme di memi ripetuti e confermati dalle abitudini di vita e di relazione, in spazi fisici concreti. Però l’arrivo di nuove generazioni, senza memoria del passato e tendenzialmente creatrici di nuovi memi, provoca un cambiamento nel tempo, una deriva culturale che si sviluppa sempre nello stesso spazio fisico. E’ un processo tendenzialmente lento, salvo l’intervento di agenti “rivoluzionari” interni e/o esterni (es. movimenti politici, guerre, disastri naturali, ecc.); per derive culturali quasi totali in condizioni normali genetisti come Luca e Francesco Cavalli Sforza hanno genericamente quantificato il lasso di tempo necessario in mille anni, paragonandole alle derive genetiche (Cavalli Sforza, 1993). I sette-ottocento anni passati dall’inizio dell’uso scritto dell’italiano volgare ci rendono la lettura di molti passi delle opere del Duecento-Trecento molto difficile; per chi ha un basso livello di istruzione quasi impossibile.
Le resistenza al cambiamento delle isole culturali dipende dal contesto spaziale, dagli eventi storici, dallo scambio/contatto con altre isole, dalle caratteristiche specifiche dei memi delle singole culture e da quanto questi memi vengono sistematicamente praticati nella vita quotidiana di relazione. L’imitazione dei simili e la pratica continua sono probabilmente i due principali fattori di resilienza delle isole culturali.
La deriva culturale avviene anche per spostamento in un altro spazio fisico; esempio principale il fenomeno migratorio. Un gruppo umano che si muove in uno spazio fisico diverso da quello della propria isola culturale si porta dietro i propri memi e tende a riprodurli nel nuovo contesto. La lingua parlata è il veicolo fondante di questo tentativo di riprodurre/mantenere la propria isola culturale. La ricostituzione di aree (soprattutto cittadine) e di comunità su base linguistica è il tratto più diffuso, ripetuto e interculturale del fenomeno migratorio. Perché nel volere vivere nel gruppo di simili coi quali puoi parlare e farti capire, in questo meccanismo-meme psicologico, gli esseri umani sono tutti decisamente uguali.“Sarebbero le barriere linguistiche a rafforzare l’isolamento genetico e viceversa” (Farinelli, 2003, p.74, riferendosi a Cavalli Sforza, Menozzi e Piazza, 1994).
Ma la barriera linguistica non può resistere a lungo in certi contesti; questo tipo di deriva culturale deve fare i conti con nuovi e diversi fattori rispetto al processo di cambiamento interno delle isole culturali che rimangono nello stesso spazio fisico. Per prima cosa le condizioni fisico-ambientali del territorio di arrivo (ad esempio nuove condizioni climatiche provocano cambiamenti nell’alimentazione, nel modo di vestire), in secondo luogo la consistenza numerica del gruppo umano eventualmente già presente. Arrivare in uno spazio vuoto o quasi facilita la ricostituzione dell’isola culturale (vedi quanto sono ancora “British” Australia e Nuova Zelanda), mentre l’essere minoritari in una società già costituita e organizzata obbliga alla “negoziazione”, alla rinuncia o modifica delle proprie abitudini anche se tendenzialmente si cerca di mantenere la vicinanza fisica con chi parla la tua lingua e condivide la tipologia delle relazioni sociali; vedi ad esempio le Chinatown o le Little Italy nel mondo. Come pure sono significativi i casi di lingue o dialetti marginali che rischiano l’estinzione (o sono quasi estinti) nei luoghi di origine, ma che mantengono la loro fissità, ormai anche un poco arcaica, a New York (censiti più di 800) perché i parlanti la tengono in vita grazie al fatto che continuano ad usarle per le relazioni sociali interne al gruppo (Scevola, 2010).
Nonostante ciò figli e nipoti, le seconde e terze generazioni, manifestano i segni evidenti del processo di deriva culturale. Questi acquisiscono una doppia comprensione linguistica e vivono in uno spazio fisico che per loro non è “nuovo”, ma il proprio, e quindi subiscono l’effetto di memi più differenziati rispetto a genitori e nonni e nello stesso tempo ne producono di originali. Che hanno effetti anche sulla comunità preesistente (soggetta anch’essa al processo di deriva culturale) a seconda della consistenza numerica del gruppo di recente immigrazione e anche della tipologia e dell’impatto dei memi culturali di cui sono portatori (i memi del legame di sangue famigliare sono tra i più potenti e stabili, ma la diffusione del consumo della pizza negli USA è un evidente esempio di deriva culturale al punto tale che più della metà dei giovani pensa che l’abbiano inventata loro). In ogni caso sia l’assetto del territorio (come è fatto) che gli stili di vita confermano e/o creano i memi. Nella geografia politica – geopolitica, intesa come pratica di analisi intellettuale di dinamiche in territori e tra gruppi umani, non si presta sufficiente attenzione a tali pratiche (isole e derive culturali), oppure è un’attenzione marginale e/o settoriale.
Essere epistemologicamente anarchici per capire lo spazio
William Godwin, considerato (a posteriori) il padre teorico fondatore dell’anarchismo, iniziava (1783) la sua riflessione sulle pratiche e i presupposti “ideali” dell’educazione con la frase “i due strumenti principali del potere umano sono il governo e l’educazione” (citato in Pancera, 1992, p.5). Si era ancora prima dell’affermazione ideale e pratica della necessità di impartire una educazione sistematica, generalizzata e “pubblica” ai giovani per sostenere il comportamento civico ed il benessere dei cittadini nell’era del post-Illuminismo e Godwin sottolineava che “per educazione […] io intendo il senso più comprensivo che può essere associato a questa parola, incluso ogni incidente che fa sorgere un’idea alla mente” (ibid, p.54, corsivo mio). Quest’ultimo riferimento è concettualmente vicino se non uguale all’idea di meme.
Ma certo l’azione dell’educazione oggi è sempre più dipendente dalla diffusione di memi-idea veicolati dal sistema globale dei mass media (e dei social media) piuttosto che dai sistemi scolastici. Un sistema mediatico mondiale che tende ad essere sempre più multipolare come proprietà e raggio di diffusione, ma i cui poli sono comunque strumenti al servizio di chi detiene il potere (economico e/o politico) locale o “glocale”, che ha interesse a diffondere informazioni e narratives (cioè descrizioni-racconti-rappresentazioni) che non mettano in discussione la struttura stessa del potere, qualunque forma politica essa prenda. Dal lato dei social media c’è un maggior dinamismo e certo una maggiore presenza e diffusione di “pensiero divergente” e di informazioni non censurate rispetto a quello dominante, ma i social media sono anche il terreno fertilissimo di hoax (bufale), affermazioni e tesi di ogni tipo e in ogni campo che sono campate per aria, inverificate e inverificabili. Ma che diventano punto di aggregazione volontaria (tutte, seppur in diversa misura numerica) per un certo numero di “fedeli” che provvedono a ridiffonderle seguendo lo stesso meccanismo dei memi. La forza globale del sistema mediatico “tradizionale” (TV soprattutto e stampa) rimane però ancora molto più forte soprattutto col crescere dell’età dell’utilizzatore.
E se questo meccanismo di diversione, l’azione di questo meme potente ed egoista, fosse dilagato nel campo della geopolitica e delle sue dinamiche al punto che le narratives (narrazioni) con cui vengono raccontate (e le riflessioni teoriche su di esse), come pure i discourses (quadri ideali-concettuali) che le sottendono, fossero delle invenzioni dell’immaginazione, talmente ripetute e dibattute che vengono credute vere? Che ci sia stata una trasmissione e ripetizione dei memi tra leader politici, decision makers, esperti e accademici che “sembra sia soggetta a mutare in modo non discontinuo e anche a omogeneizzarsi” (Dawkins, op.cit., p.257), creando così una “necessità” a partire da una mutazione “casuale” proprio come nel caso dei geni (Monod, 1970)? Con il risultato che si parla di territorio, di spazio, di strutture politiche spazializzate, di confini, di identità etniche quando in realtà si tratta dei “normali”, basilari comportamenti degli esseri umani, come singoli e come gruppi. La nostra atavica consapevolezza che lo spazio fisico ci è necessario, ma che “esiste” come altro da noi, ci ha portato ad attribuirgli parte del nostro pensiero e della nostra immaginazione; perché noi stessi siamo necessariamente “fisici”. Lo abbiamo umanizzato a tal punto, lo spazio, da perpetuare di generazione in generazione il meme-idea che esista un qualsiasi rapporto causa-effetto tra il luogo dove si nasce e le caratteristiche culturali, perfino intellettuali di chi vi è nato. E’ un potente e ripetuto meme che è diventato una idea-transfer (in senso psicologico).
E invece dobbiamo partire dal fondamento concettuale che la terra, di suo, non ha nessun nomos (nel senso di Carl Schmitt): sono i singoli e i gruppi umani che li inventano; per se stessi e in modo differenziato nello spazio e nel tempo.
Come geografi dobbiamo osservare lo spazio e gli esseri umani, e prestare attenzione a non confondere le caratteristiche dell’uno con quelle degli altri. Sono due soggetti diversi con un rapporto che è imprescindibile e necessario solo per gli esseri umani. Lo spazio fisico può fare a meno di noi, mentre le capacità mentali umane non possono prescindere dalla fisicità del corpo umano e dall’ambiente naturale circostante. Anche quando lo abbiamo trasformato a nostro vantaggio gli elementi fisici dello spazio artificiale che abbiamo creato hanno una “vita” propria (Weisman, 2008). Altrimenti non si romperebbero e non dovremmo mai fare manutenzione.
“Lo spazio è fondamentale in ogni forma di vita comunitaria; lo spazio è fondamentale in ogni esercizio del potere” (Foucault, 1982), “ma se il territorio è simbolo del potere” (Farinelli, 2009, p.15) per i geopolitici dominio e spazio sono gli oggetti principali della loro analisi. “Il controllo dello spazio è una delle poste in gioco del potere (insieme al controllo del tempo, del simbolico, della produzione)” (Galli, 2001, p.11). In genere gli esperti di Relazioni Internazionali o di Scienze Politiche considerano lo spazio, quando lo considerano veramente, con occhi diversi dai geografi, ma c’è chi ha una lettura più consapevole e quando dice che “la modernità intrattiene con lo spazio un rapporto particolarmente difficile” tiene a precisare “lo spazio inteso in senso naturale” (ibid., p.12)
Ma il dominio cambia frequentemente forma e strumenti e quindi la nostra analisi deve usare strumenti adeguati per comprenderne a fondo le dinamiche. Strumenti flessibili, dinamici, anche creativi; si lavora con metodo, ma senza “un/il” metodo.
Troppo anarchico, troppo caos? “L’auto-organizzazione si nutre di disordine, che sa trasformare in ordine” (Farinelli, 2003, p.180). E’ una delle componenti della “sfida anarchica” quella di “azzardare chiavi di lettura e soluzioni inedite ai problemi organizzativi della società (l’assenza di dominio come stile plurale di vita)…” (Vaccaro, 2009).
Le caratteristiche umane, psicologiche e istintuali, rimangono nel tempo e in questo senso le dobbiamo considerare come “fisiche” cioè connaturate all’essere umano; siamo obbligati fisicamente a pensare e ad avere immaginazione come ad avere fame, dormire, ecc..
Si dovrebbe cercare di usare gli strumenti di analisi che fanno riferimento all’insieme di quelle caratteristiche umane, attingendo liberamente da qualunque sollecitazione intellettuale e combinandoli senza pregiudizi di “metodo” a priori, ma con un atteggiamento che Paul Feyerabend ha chiamato anarchismo epistemologico (Feyerabend, 2002, p.155). Feyerabend ha sottolineato la sua diffidenza per l’anarchismo politico a causa dell’accettazione della violenza per la distruzione delle regole sociali imposte e per la critica, che gli fa, di essere troppo fiducioso nella funzione sempre progressista della “scienza”, che invece lui stesso denuncia come una struttura mentale e sociale ormai costituita in forma di potere. Ma nel recente confronto teorico a proposito di post-modernismo e post-anarchismo non trova spazio la divisibilità tra il pensiero teorico e la prospettiva politica (che casomai è una pecca/mancanza del pensiero post-moderno), e si concorda che “l’anarchismo è un sistema filosofico che incorpora le teorie del potere, la soggettività, la storia, la libertà, l’etica e la società” (Newman S., 2001).
Piramidi spaziali e caging
In campo socio-antropologico e geografico l’approccio epistemologicamente anarchico parte dalla considerazione che quasi tutte le società umane sono organizzate secondo una piramide socio-economica fondata sulla diseguaglianza. Ma questa è una considerazione condivisa a largo raggio: “la distribuzione delle ricchezze [….] è semplicemente il risultato del potere puro e semplice. La ricchezza genera potere, quel potere che consente alla classe dominante di mantenere quella ricchezza.” (Stiglitz, 2006, p. 157)
In alto il ristretto numero di chi decide e/o controlla il potere economico e poi verso il basso il numero sempre più crescente di chi ha meno potere e reddito. Elisée Reclus (1905) indicava questo come una delle “leggi” (nel senso della frequenza) dei gruppi umani, cioè la tendenza di questi a organizzarsi in gruppi gerarchici; tale tendenza è contrastata dalla irrefrenabile spinta alla libertà dei singoli individui e per Reclus le dinamiche delle relazioni umane erano osservabili e spiegabili con la continua oscillazione tra queste due spinte contrastanti. Sostanzialmente come nel Tao il bianco e il nero, l’uno necessario all’altro, continuano a confrontarsi dinamicamente senza possibilità che uno prevalga sull’altro, producendo stabilità ed equilibrio in ogni attimo, all’interno di un continuo dinamismo.
E lo spazio fisico è l’oggetto, il campo di azione e di manifestazione di queste due forze in equilibrio dinamico e quindi costituisce il “soggetto” di studio del geografo perché lì si cristallizza la piramide gerarchica e si manifestano le relazioni umane; dove i memi “prendono corpo” e forma spaziale.
Oggi più che mai, in un mondo che si suppone globalizzato, dovremmo leggere le dinamiche geopolitiche e le strutture socioeconomiche dei diversi gruppi umani non restando intrappolati nei memi quali “stati”, “identità”, “culture” “etnie”, “guerre”, ecc., ma partendo dalle semplici e chiare manifestazioni spaziali dei rapporti di potere che si dispiegano nello spazio fisico, che ne condizionano il suo uso, che lo “costruiscono” e lo “rappresentano”.
Dinamiche di potere spaziale che si potrebbero definire forse meglio in processi largamente diffusi di caging e selfcaging.
Ogni gruppo umano organizza la vita di relazione (e di potere) nello spazio fisico ed è in grado di essere autonomo nell’elaborazione dei propri criteri “giusti” di relazione, nel formare la propria isola culturale. Le forme politiche di questa autonomia e i principi che la sottendono sono oggetto di confronto interno, discussione, anche conflitto; le forme di struttura decisionale sono sempre il risultato di una elaborazione teorica sviluppata nel tempo e che può cambiare (ad esempio in Europa il passaggio dalla monarchia assoluta a quella costituzionale fino alla democrazia parlamentare); anche per la relazione/contatto con altre forme di elaborazione autonoma. Per poter durare nel tempo le strutture politiche e le ”regole” della vita sociale si devono fondare su caratteristiche istintuali, comportamentali e psicologiche presenti in tutti gli esseri umani, che tuttavia possono “sostenere” forme diverse di regole e abitudini. Quando ciò si verifica vediamo che strutture politico-sociali, anche diversissime e tra loro contraddittorie, durano per periodi lunghi (anche lunghissimi), ma in spazi differenti. L’idea di impero della Cina e il comunitarismo di villaggio dell’Africa sub sahariana ne sono l’esempio più chiaro.
Le piramidi socioeconomiche attuali fondamentali dell’azione (geo)politica negli spazi fisici sono sostanzialmente due: 1) c’è la piramide dell’iconografia (nel senso di Jean Gottmann, 1952), quella del sangue e/o dell’onore oppure dell’ideologia o della teocrazia, e poi 2) quella della circolazione (sempre nel senso di Gottmann), cioè economica e dei soldi; più rigida nella mobilità interna la prima, più dinamica la seconda, ma ambedue necessariamente, strutturalmente piramidali. I due modelli fondamentali di piramide si possono sovrapporre/intrecciare dando luce, per deriva culturale, a differenti strutture decisionali legate a isole culturali in spazi identificabili.
Il che comporta che l’azione della politica di potere si esercita tramite la stratificazione e la separazione degli spazi fisici e la differenziazione nel loro uso come,ad esempio, il privilegio nella qualità e nell’esclusività degli spazi dell’apartheid sudafricana fino al 1994 e non solo (Yiftachel, 2012). Come siamo oggi in presenza della guerra asimmetrica, così abbiamo (e c’è dagli inizi della storia dei gruppi umani, anche se in misure e modalità differenti nel tempo) un uso asimmetrico dello spazio fisico in base al potere detenuto/esercitato.
A partire da queste due strutture piramidali fondanti, nel mondo (cioè nello spazio fisico) ci sono diverse e numerose combinazioni (sovrapposizioni e/o varianti) delle due piramidi, giustificate da chi le controlla in base a riferimenti a valori ideali “naturali” e/o “universali” o culturali (la rappresentazione simbolica, iconografica dei “valori” e delle “tradizioni” ) e che oggi hanno preso in larga parte la forma dello stato (di vari stati) come struttura e modalità operative. Le varie tipologie di stato presenti nel mondo hanno a che fare con le caratteristiche dell’isola culturale dove si sviluppano; cambia il modo di funzionare e di operare dello stato, ma non cambia la struttura socio-economica che è sempre piramidale.
A differenza dei tempi di Reclus oggi siamo ben più consapevoli che il “potere” si esercita non solo a partire dal vertice della piramide e dallo stato, ma che tutti sono in grado di esercitare un potere, non importa quale che sia la posizione relativa nella piramide socio-economica (Foucault, 2001). Cambia solo il “peso” e la portata spaziale dell’esercizio del potere. Può essere quello del padre nei confronti dei figli, o del marito/fidanzato nei confronti della moglie/fidanzata, o del dirigente nei confronti del sottoposto, del burocrate, del poliziotto che chiede la mancia, ma anche del più forte, del furbo, del bullo nei confronti dei pari grado, fino ad arrivare allo stato e alle sue istituzioni. In un contesto di potere ogni individuo lo esercita secondo le proprie possibilità e inclinazioni, ma la differenza di efficacia e di potenza tra chi agisce dalla punta della piramide e chi no rimane; è più potente il ministro dell’interno che il poliziotto che vediamo in televisione picchiare o sparare per reprimere una manifestazione non autorizzata. La fisicità degli atti ci lascia intendere i contesti di potere.
Ogni forma di potere, a qualunque livello, si trasforma in un processo di ingabbiamento, di caging, che viene esercitato (rin)chiudendo (ma anche escludendo da) spazi fisici e anche mentali, cioè limitando la possibilità di pensare un’azione, nei casi estremi perfino la possibilità di immaginare. Al regista iraniano Jafar Panahi è stato proibito perfino di pensare ad un film: il processo di caging è sempre un processo di potere. Ma Panahi ha messo una minicamera sulla sua auto ed ha prodotto un “film” basato sulle parole e le vicende delle persone a cui ha dato un passaggio (“Taxi”, Orso d’oro al festival di Berlino 2015).
La rilevanza delle Iconografie nel selfcaging
Ma perché i molti che hanno ben poco potere e/o reddito accettano una situazione che li vede maggioritari come numero e minoritari come possibilità d’azione e di decisione? Che li vede spesso ingabbiati o esclusi?
Perché la struttura sociale, il discourse culturale, lo spazio fisico del locale, quello dell’esperienza (Taylor, 1982), in cui si nasce e si cresce ha un “senso” così come è; per il solo fisico fatto di esserci e viverci. “Noi accettiamo la realtà del mondo così come ci si presenta” (detto dal personaggio Christof, regista del Truman Show nel film di Peter Weir, The Truman Show, 2005). E mantenere questo senso, tendenzialmente immutato, dà sicurezza. Rappresenta un’isola culturale che difficilmente viene messa in discussione a livello di massa. Inoltre il “senso” di un’isola culturale viene continuamente alimentato (e a volte costruito volutamente per fini politici) grazie a quelle che Jean Gottmann (1952) ha definito Iconography, quel complesso di memi di riferimento che si strutturano stabilmente e che danno sicurezza e senso di appartenenza, soddisfacendo alcuni dei più profondi bisogni psicologici degli essere umani. Tutti questi memi “forniscono una risposta superficiale plausibile a problemi profondi e inquietanti dell’esistenza” (Dawkins, 1995, p. 255) e il meccanismo simile a quello della selezione naturale “favorisce i memi che sfruttano a proprio vantaggio l’ambiente culturale” (ibid, p.262); cioè le cosiddette “tradizioni”, le “identità”, o più semplicemente i luoghi comuni e le abitudini quotidiane, quali che siano. Questo è essenzialmente il processo quotidiano e diffuso dell’autoingabbiamento, del selfcaging. Fare scelte dichiarate e vissute come libere che portano a comportamenti imitativi omogenei e largamente condivisi (portare il velo nel mondo musulmano o cambiare colore e/o pettinatura nel mondo occidentale).
Si tratta di un meccanismo comportamentale tipicamente umano e quindi largamente diffuso soprattutto perché inconsapevole. Ma non sempre obbligato e senza via di scampo. Gli esseri umani hanno tutti una spinta individuale (che in certi contesti e condizioni può diventare diffusa e collettiva) al cambiamento, alla scoperta; Gottmann l’ha definita Circulation e sembra molto simile concettualmente alla insopprimibile spinta degli individui verso la libertà affermata da Reclus. E anche Dawkins ricorda che un aspetto unico dell’uomo “è la sua capacità di previsione conscia”, quindi “abbiamo il potere di ribellarci ai nostri creatori” (ibid., p.264). ). “Volgere lo sguardo alle nostre appartenenze permette di acquisire coscienza di dinamiche di socio potere che subiamo inconsciamente e che dettano il nostro agire (Boni, 2011, p.205).
Dovrebbe valere anche per i geopolitici, per i giornalisti, per gli accademici, per gli esperti di Relazioni Internazionali e per gli attori delle dinamiche geopolitiche (leader di governo). Ma viene il dubbio che non sia così. O almeno che non lo sia se non occasionalmente; perché come esseri umani tutti siamo dentro la dinamica del caging-selfcaging e delle iconografie mentali consolidate.
Le Iconographies sono rappresentate oggi non solo dalle manifestazioni simboliche e retoriche dello stato e dell’autorità in genere, ma anche dai fenomeni di massa, che si manifestano in dimensioni sempre più globali: calcio, moda e mode, consumismo, programmi TV, film, comportamenti che vengono visti e imitati, ripresi e diffusi (vedi YouTube, Istagram e Tik Tok, ecc.), culto di personalità (persone famose, influencer o leader), ecc.. Non c’è differenza tra questi memi e i meccanismi mentali geopolitici che producono e diffondono memi-idea come nazione, identità, etnia, legame emozionale con la “mia terra”, (in)sicurezza, indipendenza, autodeterminazione, l’Altro cattivo, la pace, terrorismo, Occidente, Islam, ecc.. E come nel caso citato della “rete” il processo di caging, di irrigidimento tramite iconografie passa sempre di più attraverso una narrative di libertà di scelta individuale e/o di “valori” scelti senza costrizioni e spesso pensati come universali. Ed è il paradosso anche del selfcaging, cioè della nostra “scelta” di costruirci volontariamente la nostra gabbia nei gesti quotidiani; da non prendere solo nell’accezione negativa di privazione. Banalmente tendiamo a ripetere lo stesso percorso per fare la spesa, per prendere il giornale, siamo ripetitivi nel frequentare gli amici, cerchiamo omogeneità/vicinanze culturali o di classe sociale nella scelta della scuola per i figli, nel scegliere e arredare la nostra casa … all’Ikea. Ci si sente liberi perché abbiamo “scelto” o magari attivato uno o più gruppi su Facebook e milioni di individui cedono volontariamente, a un sistema gestito da pochi per fare un mucchio di soldi, informazioni personali che poi si cerca di proteggere con difficoltà tramite l’approvazione di leggi che garantiscano la privacy sui dati sensibili personali.
E allora il quotidiano “giusto” o il canale televisivo o il sito web migliore è quello che dice o mostra quello di cui siamo già convinti; è “la tendenza naturale a cercare elementi di prova che corrispondano alle nostre idee preconcette e a crederci, ignorando tutto il resto” (Giles, 2010).
Se questa è la dinamica diffusa e dominante, allora, forse anche noi geopolitici abbiamo contribuito a sviluppare una deriva culturale che ci ha portato alla costruzione di una isola culturale in cui, mostrando anche sofisticate capacità di analisi, dibattiamo e approfondiamo con grande dispendio di intelligenze e pagine stampate concetti, teorie, dinamiche, ecc. che sono solo la rappresentazione della realtà. Siamo talmente immersi nella piramide socio-economica e di potere (e delle sue iconografie) che non ne abbiamo quasi più percezione; e quello che è più grave è che dando per scontato lo spazio fisico non lo osserviamo più con la dovuta capacità di analisi; umanizziamo la fisicità e dimentichiamo la fisicità umana.
Allora, forse, la banalità, la semplicità della condizione umana e delle sua necessità fisiche, e nel contempo la consapevolezza della complessità della psicologia umana sono più utili per capire conflitti e dinamiche; e quindi nelle nostre riflessioni bisogna dare centralità, considerare come fattori decisivi “geopolitici”, più importanti di altri per quanto riguarda le motivazioni comportamentali, le esigenze di base, fisiche, degli esseri umani: bere, mangiare, dormire, avere bisogni corporali, fare sesso, avere vestiti e una casa adeguati al clima. E quelle psicologiche che possiamo considerare come necessità “fisiche” della mente umana, cioè quei meccanismi biologico-istintivi che sono presenti in tutti gli esseri umani e che non derivano dai memi anche se ne vengono fortemente influenzati: vivere in gruppo, essere apprezzati, essere solidali, proteggere i piccoli, sognare il futuro (soprattutto per i figli) e avere desideri, avere “cattivi pensieri” (come l’invidia e la rabbia), avere paura, avere consapevolezza della morte. La crescente pressione migratoria cui è stata sottoposta l’Europa negli ultimi anni e soprattutto nel 2014-2016, per la mancata soluzione della questione siriana (e di altre) oltre che per la permanente disparità economica mondiale, nasce proprio da quei “bisogni” che sono basici. I flussi migratori superano ostacoli fisici (naturali o artificiali) e quando non ci riescono (o vengono bloccati in un punto) sanno trovare e si reindirizzano verso altri punti più “deboli”.
La qualità della vita quotidiana è un fattore geopolitico.
A titolo di esempio nel caso della Striscia di Gaza, il blocco del movimento delle persone, il contingentamento fisico dei beni in entrata e il processo di caging che queste cose innescano sono elementi rilevanti, il punto di partenza per capire quella dinamica geopolitica (e sicuramente per cercare soluzioni) al pari, se non di più, delle dichiarazioni iconografiche (scontate e ripetitive) di un qualsiasi esponente di Hamas o di un ministro israeliano. L’affermazione iconografica del caging esterno (sicurezza di Israele in pericolo) consente al governo israeliano, tramite i mass media e l’azione militare, un caging della e nella Striscia, fisicamente asimmetrico, come numero di privazioni, vittime e distruzioni, rispetto ai danni verso Israele dei razzi Qassam. E grazie all’ingabbiamento fisico della Striscia ed al suo valore iconografico i leader di Hamas operano un caging sulla popolazione palestinese che è giocato sia sui simboli che sull’uso degli spazi fisici. L’iconografia dell’Islam si traduce in slogan e gesti retorici, in comportamenti ammessi o proibiti e sorvegliati dalla milizia; quella della resistenza armata al sionismo si materializza nel lancio di razzi Qassam che certo non ha prospettive di vittoria. Ma intanto Hamas non ha concorrenti nella gestione del potere.
Del resto l’intervento strutturale sull’altro territorio palestinese della West Bank, operato tramite gli insediamenti/colonie in stile occidentale e in continua espansione, e il complesso delle comunicazioni stradali, sono indicatori e fattori fondanti del processo di caging, sotto la forma di check-point, Muro-“fence”, strade vietate-separate, e selfcaging che diventa esclusività ebraica, anche come stile di vita, negli outpost illegali e in quasi tutti gli insediamenti tollerati o autorizzati dal governo (Weizman, 2009). Le forme del processo sono diverse (anche per l’evidente enorme differenziale di disponibilità economica tra lo stato di Israele e l’Autorità Palestinese), ma la dinamica è la stessa che a Gaza. Lo spazio fisico (bloccato o modificato) che diventa condizionante geopoliticamente e produce comportamenti e azioni “geopolitiche”, prevalentemente una abitudine/assuefazione mentale alle condizioni di vita quotidiane oppure un minoritario senso di ribellione. Che comunque non può essere sconfitto proprio per la fisicità quotidiana dell’esercizio squilibrato e asimmetrico del potere che continua ad alimentare il senso di ingiustizia.
Manifestazioni spaziali e comportamentali (selfcaging) della differenziazione primaria
Se sono le esigenze umane che sostengono (o provocano) le dinamiche geopolitiche i criteri e gli strumenti di analisi cambiano: la differenziazione più evidente nella piramide socio-economica e nella gestione-soddisfacimento delle esigenze citate è quella tra ricchi e poveri, tra privilegiati e esclusi, tra sfruttati e sfruttatori, tra chi può decidere e chi deve subire; a prescindere dalle dichiarate appartenenze nazionali, dalle pretese identitarie, culturali, valoriali, ecc.. E appare significativo che in questo tipo di struttura gerarchico-piramidale fondata sui soldi il mondo legale e quello criminale non hanno obiettivi differenti; cambiano i modi e gli strumenti d’azione, ma non sempre. Anzi, sempre più le modalità operative dell’economia criminale e del riciclaggio dei soldi “sporchi” si intreccia sinergicamente col processo di finanziarizzazione globale dell’economia (Galullo, 2010), si manifesta concretamente nel controllo e negli effetti che ha sul territorio oltre che sulle persone. Vale la pena di ricordare che la crisi finanziaria mondiale del 2007-09 ha avuto la sue radici nella disinvolta gestione dei mutui per l’acquisto di un bene primario ed essenziale per la vita umana come l’abitazione e che edilizia e infrastrutture sono tra i principali settori di investimento in cui le mafie nazionali e internazionali gradiscono “lavare” i proventi dei traffici illeciti. Non c’è stata crisi economica-finanziaria degli ultimi 30-40 anni che non sia stata preceduta da una cosiddetta “bolla immobiliare”. E’ la “particolare logica dell’industria finanziaria, tipicamente gerarchica e selettiva: mentre le sue attività si estendono alla sua base in continuazione, al tempo stesso cresce la concentrazione al vertice” (Farinelli, 2003, p.195).
Le differenze di reddito e potere incidono direttamente sia nel soddisfacimento dei bisogni primari sia nel “sogno” e nell’immaginario; e incidono direttamente anche nella proprietà e nell’uso differenziato degli spazi fisici, nella determinazione della loro forma e dimensione. L’abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni sotto la forma dello zoning dei quartieri cittadini, testimoniato dal costo differenziale per metro quadrato e da qualità-tipologia dei materiali usati come pure dall’aspetto delle case; con oscillazioni estreme che vanno dalle comunità fortezza e super sorvegliate dei ricchi agli enormi quartieri-slums delle metropoli dei paesi poveri. Dice il noto architetto italiano Vittorio Gregotti: “la città più che accogliere seleziona, produce scarti sotto forma di quantità crescente di immondizie, ma anche di esuberi umani che il potere tenta di contenere in recinti. Il recinto, lo spazio sorvegliato (ricchissimo o poverissimo) è quindi un’idea che va molto al di là del tema della sicurezza, è il principio di una concezione della stessa città come somma di ‘accampamenti’ reciprocamente impermeabili” (Corriere della Sera, 27 luglio 2010, p.39).
Ma questa differenziazione primaria è presente anche nelle culture non urbane e anche lì si fonda sull’uso differenziato dello spazio fisico, come pure sulla differente qualità e quantità di proprietà di “cose”, sulla differente possibilità di incidere sui cambiamenti nello spazio fisico e sui comportamenti del gruppo.
L’asimmetria ricco/povero innesca un meccanismo per cui tendenzialmente ci si rinchiude (o si è costretti a rinchiudersi) in spazi dove i vicini sono “omogenei” a noi e si innesca un processo mentale che ci fa ragionare sempre intorno agli stessi concetti e nelle stesse modalità di vita, che fa circolare sostanzialmente gli stessi memi. E’ la logica del country club/campo da golf che oggi diventa di massa col villaggio turistico e la nave da crociera. E’ il meccanismo delle eterotopie (territori-spazi “altri”) foucaultiane (Foucault, 1984).
I più giovani crescono in gabbie volute o costruite dai genitori, subiscono l’influenza “percettiva” dell’ambiente circostante e che frequentano; così pensano che il mondo, tutto lo spazio fisico, sia uguale a quello che conoscono e soprattutto che funzioni secondo le stesse abitudini che hanno visto e sperimentato. Ma diventano attori attivi di caging/selfcaging loro stessi quando copiano/ripetono comportamenti (fisicamente visibili in posti fisicamente frequentati o conosciuti tramite i mass media) o cercano luoghi dove sanno già cosa trovare: sempre quello che conoscono (come McDonald’s o KFC, o i mega centri commerciali con i vestiti e gli oggetti di moda al momento) e che dà quella tranquillità che consegue alla sensazione di esercitare un potere decisionale apparentemente autonomo, sia pure piccolo e limitato nel tempo e nello spazio; al limite basta anche solo guardare. E il Mall (centro commerciale) distrae dalla personale differenziazione di posizione nella piramide socioeconomica proprio mostrando in un ambiente accattivante e in assoluta evidenza la fisicità dei beni nelle vetrine che però possono essere acquistate solo in base alla propria posizione nella piramide. “L’individuo contemporaneo si percepisce a valuta gli altri prevalentemente in base alle scelte nel consumo” (Boni, 2009, p.150) e il Mall allo stesso tempo rafforza e nasconde che “l’esistenza economica dell’individuo viene appiattita su un paradigma unico: lavorare per guadagnare, per poi spendere come consumatore, il tutto all’interno della medesima logica mercantile” (ibid, p.147).
Il senso (voluto, subìto, accettato o vissuto inconsapevolmente) della propria isola culturale (individuale e/o di gruppo) produce un meccanismo di autoingabbiamento, di selfcaging mentale che diventa e/o produce selfcaging spaziale.
E’ un processo mentale profondamente umano, e quindi necessario, ineludibile. In questo senso protettivo ed equilibrante: ‘a home means walls’ (una casa significa muri) dice una donna migrante di oltre 80 anni che ha cambiato 17 volte “case” nella sua vita ( Tovi Fenster, conferenza su: ‘Migrant Women over 80: the Meanings of Home, Belonging and Memory’, Università Milano-Bicocca, 30 aprile 2010).
Però contrastabile quando si raggiunge la consapevolezza della sua portata politica e di potere (su di noi e sugli altri) perché anche il processo di selfcaging è un processo di potere, ma rivolto verso se stessi; molto spesso inconsapevolmente. Ma anche quando è consapevole spesso appare come “giustificato” da vantaggi, o male minore rispetto al non conosciuto/percepito, rispetto alla paura dell’ignoto o del “nemico”.
Risulta paradossale il caso estremo dei capi mafia/camorra italiani che restano latitanti per anni o anche decenni e che poi quando vengono scoperti e arrestati si scopre che pur di potere esercitare il potere, perfino di vita e di morte (caging estremo), hanno vissuto prevalentemente rinchiusi in spazi piccoli o squallidi (selfcaging) insieme a quantità enormi di soldi (lì inutili), con videogiochi, giornali sportivi e immagini della religiosità cattolica popolare. Ma hanno investito in molte proprietà immobiliari e nel possesso della terra che non utilizzano se non occasionalmente o servono al funzionamento della struttura gerarchica e delle attività criminali.
Il geografo osserva lo spazio pubblico/privato, e inizia a considerarlo dal punto di vista fisico
Se accettiamo queste premesse, come possiamo, come intellettuali e geopolitici, affinare la nostra consapevolezza di tali meccanismi? Quali accorgimenti/criteri selettivi usare? Come uscire dal nostro selfcaging intellettuale?
Il modo è quello tipico del geografo: osservare con attenzione. Seguendo il suggerimento di Gerard Toal (1996) “an educated geographer is an observer” perché “Geography is seeing, not writing” (“un geografo ‘educato’ è un osservatore” perché “la geografia è vedere e non scrivere”).
Il cosa da osservare è principalmente la tripartizione dello spazio (Eva, 2012); poi il tipo di relazioni umane che vi agiscono.
Significa considerare, “vedere”, lo spazio da tre punti di vista: come fisico [-biologico] (la materialità di tutto ciò che non ha consapevolezza della propria morte, compresa la fisicità degli esseri umani), come percepito (tutto ciò che è soggettivo, emozionale, di ogni singolo essere umano), come rappresentato/simbolico (tutto ciò che viene raccontato da narratives o asserito tramite l’attribuzione di valore metafisico o trascendente, anche attraverso simboli da accettare come icone [indiscutibili]).
Con l’approccio suggerito dal creativo pensatore anarchico Colin Ward, attivo nell’auto-organizzazione territoriale e nell’educazione, scomparso nel 2010, che diceva “tendo a pensare in termini di esempi pratici o di esempi concreti” (citato in Goodway, 2003, p.69).
Lo spazio percepito (quello che noi crediamo di vedere come oggettivo mentre invece lo interpretiamo) è quello che sostiene il processo di selfcaging.
Lo spazio rappresentato/simbolico (quello che ci viene descritto/raccontato o che affermiamo come vero e/o pieno di significato) sostiene il processo del caging.
Questi sì sono meccanismi a fortissima (ma non totale) influenza psicologica; molto più di quanto in passato si pensasse fosse il condizionamento determinista dello spazio fisico (ambiente e clima) sui comportamenti dei gruppi umani e dei singoli. Il successo avuto dalla tesi di Samuel Huntington della Clash of civilization (1993) mostra come oggi “il senso comune” attribuisca alla “cultura” (civilization) la stessa forza determinista che si attribuiva un tempo alla natura. “Il senso comune si nutre quindi di discorsi falsi ma potenti perché appetibili, seduttivi, introiettati e riprodotti nella prassi, a volte diffusi con caratteristiche analoghe in molti circuiti culturali” (Boni, 2011, p.193).
Ma il primo e fondamentale punto di partenza per il geografo (e il geopolitico), il suo approccio metodologico deve essere l’attenta osservazione dello spazio fisico, di una materialità (anche biologica) che è altro da noi, a partire dagli oggetti e dalla fisicità della nostra vita quotidiana, ma che include quello che in noi è fisico come la necessità di bere e mangiare, ecc., e che comprende anche la necessità di avere immaginazione. Una materialità così come è, a prescindere da “noi” come umanità, dai suoi rapporti con essa, dalle modifiche che gli esseri umani sono in grado di introdurre o hanno introdotto; e questo ci aiuta a liberarci dai pregiudizi (la percezione degli altri e di cosa ci circonda) e dalle costruzioni/incrostazioni mentali che ci “inventiamo” o che ci vengono somministrate (i memi del nostro immaginario e/o delle iconografie). A partire dallo spazio fisico possiamo leggere con più precisione la concretizzazione della piramide socio-economica e dei vincoli/condizionamenti all’agire umano (ad esempio la forma e la distribuzione delle case, la configurazione degli spazi pubblici e la loro fruibilità, le zone private/protette/esclusive, ecc.); perché se riusciamo a considerare la materialità dello spazio possiamo vedere e comprendere meglio le conseguenze fisiche dell’azione dei gruppi e dei singoli, e comprendere come si articolano le relazioni socioeconomiche in quel luogo, il diverso uso che dello spazio fanno i singoli e i gruppi. E anche le “forme” dell’immaginario che agisce in quel luogo.
E dunque, come geopolitici, di fronte a crisi più o meno conflittuali o a dinamiche che sembrano complesse invece di “chi comanda qui, e cosa pensa o dice di essere o voler fare?” possiamo domandarci “com’è strutturato lo spazio fisico ‘locale’? Cosa è frutto del caging e cosa del selfcaging? Gli esseri umani, qui, di cosa hanno bisogno materialmente o cosa vorrebbero per una vita degna di essere vissuta?”. Osservare con attenzione e provare a rispondere a queste domande può fare di noi geopolitici soggetti utili a favorire processi di pace invece che analisti abili a descrivere gli effetti territoriali delle decisioni di chi comanda. Non perché le decisioni dei leader siano ininfluenti, ma proprio per capire meglio da dove vengono e che effetti possono produrre.
“Là dove la modernità ritiene di assistere all’azione di soggetti, occorre sforzarsi di vedere solo reti di pratiche contingenti, di constatare che avvengono cose, che succedono fatti” (Garcia, 2009).
A titolo di esempio, per sostenere o innescare processi negoziali di convivenza nello spazio e/o di pacificazione nei territori contesi in Israele/Palestina (Newman D., 1996) la questione nodale, fondamentale, non è quella della rappresentazione e di chi ha titolo per negoziare (si deve trattare con Hamas? E Hamas deve trattare con Israele?), ma è quella di come limitare disuguaglianze e privilegi (Eva, 1999), e limitare la portata e la proprietà degli spazi privati (senza farli sparire), visto che il controllo esclusivo dello spazio senza limitazione “concettuale” è uno dei pilastri simbolici e fattuale della piramide socio-economica e del processo di caging-selfcaging, che sono fattori generatori di conflitti. Dare risposte “fisiche” ai bisogni umani costituisce la base irrinunciabile di qualsiasi processo di pace; e questo ha bisogno di tempo, che però deve essere reso visibile da cambiamenti effettivi nello spazio fisico. Certo, ogni processo di pacificazione va sostenuto anche sul piano del percepito e del simbolico, ma i suoi effetti devono essere fisicamente visibili nella vita quotidiana. Affinché il processo di pace possa diventare una idea-transfert.
E’ curioso che gli spazi privati, la loro quantità, estensione, “protezione”, tipologia, non compaiano mai nelle analisi geopolitiche e nelle relazioni internazionali come fattori significativi. Gli spazi privati sembrano a-politici per definizione, perché non sono condivisi e al loro interno si danno regole d’uso autonome. Ma queste regole autonome sono quasi del tutto simili a quelle degli spazi pubblici gerarchici; perché si fondano sullo stesso atteggiamento mentale “piramidale”. Unica differenza sostanziale: negli spazi privati, in particolare economici, è esplicita e rivendicata la gerarchia di potere e/o l’esclusione dei molti dai processi decisionali. Ed è questa la più diffusa condizione di vita di noi tutti, il nostro caging quotidiano. La quantità di spazi privati dove spendiamo buona parte della nostra vita (lavoro e abitazione) è piuttosto consistente e sostiene la continua riproduzione del meme della “presenza del dominio come categoria centrale dell’immaginario sociale” (Bertolo, 2010, p. 86).
La ricchezza personale allarga non solo lo spazio fisico privato a disposizione, ma anche la quantità e la qualità di utilizzo degli spazi pubblici-condivisi; a chi ha meno o nessuna ricchezza rimangono solo questi ultimi, che gli appartengono solo formalmente e sul cui uso hanno solo un limitato (a volte limitatissimo o nullo) potere decisionale, quasi sempre indiretto.
L’azione della politica interviene principalmente sulle dinamiche e le relazioni negli spazi pubblici, quelli che necessariamente sono e devono essere condivisi e dove possono sorgere i momenti di conflitto visto che è qui che può dispiegarsi il processo di caging esercitato dal potere decisionale (politico e/o economico) e di selfcaging esercitato dai singoli individui e dai gruppi su se stessi. Ma dove è anche possibile una negoziazione più dinamica e aperta, perché negli spazi privati, invece, il meccanismo dell’esclusione e dell’esclusività della possibilità decisionale rende la negoziazione molto ridotta se non esclusa del tutto. Comanda il “capo” e/o chi è proprietario.
Chi negozia processi di pace deve confrontarsi su questioni concrete, relative allo spazio fisico e trovare proposte che affrontino/risolvano le necessità basilari, quotidiane degli esseri umani; e anche pensare come sostenere nel tempo il processo tramite “memi-iconografie” che favoriscano il confronto e la “circolazione”, perché i nemici più agguerriti sono i memi derivanti dalle percezioni soggettive della paura e dalle rappresentazioni iconografiche del potere, dal meme della spazializzazione esclusiva delle identità.
Con particolare attenzione agli spazi pubblici.
Nello spazio pubblico la negoziazione invece della piramide. Quali modelli?
Gli spazi pubblici possono e devono essere spazi di condivisione, ma le pratiche di relazione, le abitudini di vita, sono culturalmente orientate/determinate e i diversi possibili presupposti culturali della condivisione (cioè come si manifestano i processi di caging/selfcaging) differenziano sensibilmente la loro fruizione e funzione da parte degli individui. Oltre alla differenziazione per disponibilità economica la differenziazione di genere, cioè cosa possono o non possono fare le donne, è la differenziazione “culturale” di uso degli spazi pubblici (ma anche privati) più evidente in tal senso, globalizzata e con rilevanti effetti geopolitici, tendenzialmente sottostimati nella geopolitica non critica (dell’Agnese, 2005).
Però, al di là delle diversità apparenti, i modelli culturali di piramide socio-economica in azione sono sempre i due già citati all’inizio:
Modello 1 = onore/sangue o ideologia o teocrazia, Modello 2 = economia/soldi;.
Un terzo modello sarebbe auspicabile e ci sarebbero anche esempi già praticati e/o in corso (es. il Confederalismo democratico in Rojava, nord-est della Siria, che propone e cerca di praticare le iconografie di femminismo, ecologia e democrazia dal basso, con lo slogan “donne, vita, libertà”).
Modello 1 = Lo spazio pubblico può essere condiviso, ma subendo una autorità gerarchica che ne “irrigidisce” l’uso con regole esplicite e cogenti, con “valori” affermati come giusti e quindi indiscutibili, e con sistemi di controllo forti e diffusi. La possibilità del conflitto (talvolta anche del dissenso) è negata per principio (esempio estremo la Corea del Nord), ma non può impedire scoppi violenti di insofferenza e rivolta (vedi l’Iran dopo le elezioni di metà 2009 e dal 2022 il movimento delle donne contro il velo obbligatorio, o la resistenza dei monaci buddisti in Myanmar/Birmania nel 2008, o il fatti di Tunisia, Egitto, Siria, Yemen, ecc. a inizio 2011, le cosiddette “primavere arabe”).
Modello 2 = lo spazio pubblico può essere condiviso senza conflitti destabilizzanti perché è in opera o è stato “costruito” (Iconografia) un immaginario di condivisione (meme della coesione nazionale oppure della società “migliore” perché democratica) che però produce un’isola culturale anch’essa tendenzialmente totalizzante. Il singolo vi si adagia per quieto vivere, o perché non la avverte, oppure perché la condivide e non ha ragioni di opporsi (non lo pensa nemmeno come possibile); si attiva il selfcaging. Le manifestazioni conflittuali sono più diversificate, frammentarie, ma meno violente in genere e abbastanza facilmente controllate (caging) dalla struttura politica che può contare sull’appoggio silenzioso e acquiescente della maggioranza dei cittadini, anche utilmente “distratta” dai mass media. Può valere per l’Occidente che ha i suoi modi di distrazione di massa o per la Cina del dopo Deng Xiaoping che può contare da molto tempo su abitudini sociali forti e coese oltre ad un sistema di controllo efficace, “confuciano”, da parte dell’autorità politica.
Ma ogni cultura che si sente o vuole (pretende di) essere “forte” ha i propri modi di dare senso (costrittivo) alla vita sociale. Rivendicando o inventando la superiorità delle proprie tradizioni e marchiando il territorio (vedi le centinaia di simboli uguali alla bandiera della Lega Nord nella scuola pubblica elementare-media di Adro, Lombardia, nel settembre 2010, poi fatti togliere in gran parte per azione del prefetto perché illegali, dopo un esposto di una parte dei cittadini).
La Cina è un interessante caso di studio perché ha combinato alcuni elementi chiave dei due modelli indicati; finora con successo. E il trend globale sembra a chi scrive che vada verso un “modello Hong Kong”. E’ un modello che prevede/accetta la differenza di ricchezza personale (senza limiti) e un sistema decisionale gerarchico-negoziale sotto tutela economica, in cui alle cariche pubbliche (cui si accede prevalentemente per cooptazione) si riconosce l’autorità perché e fintanto che garantisce gli interessi economici dei gestori dei capitali, delle proprietà e non mette mai in discussione la legittimità della struttura di potere; i soggetti “forti” vengono cooptati nella negoziazione e nelle decisioni di ampio respiro (lobbies) e/o gli si garantisce la rappresentanza politica (quote di seggi riservate) o se la garantiscono autonomamente con il sostegno economico diretto al “proprio” candidato o partito facendo la differenza nel successo in elezioni democratiche. Alla cittadinanza di Hong Kong si consente di esprimersi, e di esprimere i propri rappresentanti, tramite elezioni multipartitiche che però non possono incidere più di una certa quota percentuale definita nel processo politico-decisionale (a HK era il 55% dei deputati). Appare significativo, però, che nelle elezioni suppletive a Hong Kong del maggio 2010, provocate volutamente dal democratico Civic Party, sia andato a votare solo il 17% degli aventi diritto. Il boicottaggio voluto/imposto da Pechino (caging) si è saldato col selfcaging (rassegnazione e senso di impotenza? Disinteresse? Antipolitica? Altre priorità?) dei cittadini e dei leader economici locali. Quando però ci sono manifestazioni possenti di piazza, soprattutto di giovani in favore di più democrazia, l’intervento del governo di Pechino, in collaborazione con le élite locali, è stato potente e la nuova legge elettorale ha ridotto a 1/3 la percentuale di rappresentanti direttamente eletti dai cittadini.
Infine (ed è il terzo auspicabile modello) lo spazio pubblico può essere condiviso perché è “negoziato”; cioè c’è un reale confronto/dibattito pubblico in cui le decisioni politiche e gestionali vengono decentrate al più basso livello possibile. Gli individui trovano un equilibrio o risolvono la conflittualità nella continua negoziazione negli spazi condivisi, ma a partire dagli spazi individuali (mentali e fisici) che vengono presupposti come uguali e per questo vengono, tramite la politica, orientati all’uguaglianza. In Italia un timido esempio sono le quote di “bilancio partecipato” (piccole percentuali dei fondi comunali) che alcuni comuni lasciano, per come utilizzarli, alla decisione diretta dei cittadini. Nel mondo in casi più noti, che dovrebbero essere più conosciuti e studiati, sono il già citato Rojava e il Chiapas “zapatista” messicano.
Ma per poter avere una negoziazione tra “uguali” gli spazi individuali devono essere limitatamente esclusivi (cioè lo spazio fisico del sé è garantito, ma deve avere una portata spaziale limitata) e limitatamente differenziati quanto a “ricchezza”, per avvicinarsi concretamente alla “posizione originaria” di John Rawls (1971). Brutalmente significa limitare la proprietà privata dello spazio perché non basta che una società si dichiari formalmente democratica e/o abbia costituzioni o norme giuridiche di equilibrio tra poteri dello stato quando gran parte (la quasi totalità) della vita quotidiana e delle relazioni politiche e economiche avvengono in dinamiche di caging/selfcaging in cui i soggetti sono diversamente dotati di poteri e strumenti di azione, di capacità e consapevolezza, di possibilità decisionale nel fissare le regole per dominare e dare forma allo spazio fisico, di differenti dimensioni di proprietà dello e nello spazio fisico. Gli effetti negativi della differenziazione primaria tra ricchi e poveri erano ben presenti ai costituenti italiani quando hanno elaborato l’articolo 3 della Costituzione ed infatti nel secondo capoverso affermano che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (corsivo mio); si veda il commento critico in merito di Gherardo Colombo (2023).
E’ un articolo che mantiene appieno la propria forza concettuale, ma per sottolineare una piccola deriva culturale dal 1948 vale la pena evidenziare l’uso della parola “lavoratori” che oggi verrebbe considerato riduttivo se non addirittura discriminante verso altre categorie sociali.
Il “modello Hong Kong” ha un corrispettivo nel sistema occidentale parlamentare che segue sempre di più l’esempio degli USA. La partecipazione (e la sovranità) dei cittadini viene sempre di più limitata al fatto elettorale (tendenzialmente con sistema maggioritario), con libertà e opportunità formalmente assolute e “uguali” di partecipazione, ma il processo di selfcaging (come pure certi meccanismi formali per esercitare il diritto di voto) porta a percentuali di votanti intorno al 50% degli aventi diritto. Anche la possibilità di scegliere cariche locali (ad esempio giudici e capo della polizia negli USA) o la frequenza dei referendum popolari (come in Svizzera) hanno una portata limitata evidenziata dal fatto che il sistema piramidale-gerarchico è “fisicamente” selettivo sempre (tramite la cooptazione dall’alto o per selezione di censo e/o ricchezza) e che gli outsiders e/o le scelte collettive controcorrente rispetto alle prassi comuni sono molto ridotti di numero e occasionali. Quasi mai “rivoluzionari” e molto spesso con l’obiettivo di conquistare il potere per irrigidire qualche pratica di caging (espulsione/contingentamento stranieri, limitazione delle diversità, restaurazione dell’ordine e del senso di appartenenza nazionale, ecc.)
Inoltre i sistemi elettorali maggioritari aumentano la rilevanza dei sistemi di conquista del consenso il cui ottenimento per vincere passa necessariamente tramite la raccolta di consistenti fondi per la campagna elettorale; e questi possono venire quasi esclusivamente o prevalentemente da singoli o da gruppi economici del vertice della piramide socioeconomica. I quali tramite l’azione di lobbying eserciteranno il loro “diritto” ad orientare/condizionare le scelte dei rappresentanti politici eletti dai cittadini (si veda la sentenza della Corte Suprema USA a proposito dei finanziamenti elettorali [liberalizzati] criticata dal presidente Obama nel suo discorso del 27 gennaio 2010). Non è un caso la crescita ed il successo elettorale nel mondo di leader politici ricchi personalmente o che rappresentano apertamente interessi economici ben individuabili oppure che hanno raggiunto la notorietà popolare grazie al sistema dei mass media; il quale sistema, necessariamente, è in maggioranza di proprietà e controllato dagli stessi soggetti del vertice della piramide socioeconomica. E chi ricco non è adeguerà il proprio programma elettorale alle aspettative dei possibili finanziatori della campagna elettorale; perché l’obiettivo è vincere.
Tramite l’infotainment si canalizza il consenso dei “clienti”-elettori grazie all’apparente differenziazione di narratives di uno stesso discourse. Da questo punto di vista si può dire che se nel modello cinese la carriera ed il confronto politico si esercitano e si sviluppano all’interno del partito, nelle democrazie parlamentari la “scuola di politica” viene fatta ormai dentro e tramite il sistema del mass media. In ambedue i casi, nella larghissima maggioranza dei casi, non si “sale” verso il vertice se non si è omogenei e quindi cooptabili dal sistema socio-economico dominante. Per paradosso il caso di una struttura sceicco-emiro come quella del Qatar da metà degli anni ’90 (dopo un colpo di stato “bianco” del figlio contro il padre) ha mostrato una capacità di cambiamento/deriva culturale rispetto al proprio contesto molto più veloce e per certi versi più rivoluzionaria di molte democrazie parlamentari; il capo unico decide e cambia le cose in fretta. E l’esempio emblematico di tale deriva culturale è l’istituzione di Al Jazeera TV che, anche per un caso fortuito, è diventata una fonte ascoltata delle narratives mediatiche internazionali, sostenendo il ruolo geopolitico crescente del Qatar. Un ruolo che non è stato solo di supporto al punto tale che Al Jazeera viene considerata e trattata come soggetto politico (in Iraq le è stato proibito di avere un ufficio e nell’Egitto con elezioni pretese “democratiche” di Al Sisi tre suoi giornalisti sono stati processati per “terrorismo” e tuttora in carcere).
I soggetti economici decisionali, le transnational corporations, si muovono sempre più a livello globale, ma hanno bisogno di ambiti territoriali fisici con confini certi e autorità politiche che garantiscano loro i titoli di proprietà e la prevedibilità delle “regole” (oltre che “favori”). Cioè il sostegno dei propri governi (nel caso degli stati più potenti a livello internazionale) e le garanzie/connivenze (più o meno valide) che possono dare i singoli governi degli stati deboli per quanto riguarda il proprio territorio; come pure la disponibilità a proprio vantaggio dell’uso legittimo della forza (cioè polizia ed esercito) e/o della favorevole tassazione che discende dallo stato. Per questo il processo di globalizzazione economico-finanziaria non fa sparire gli stati, ma ne cambia solo parzialmente le funzioni e la portata delle leggi. Modifica la rilevanza relativa delle funzioni degli stati e, potendo influire sulle modalità e le direzioni dei flussi finanziari, i soggetti leader della globalizzazione finanziaria sono in grado non solo di provocare disastri e crisi (come quella dl 2008 i cui effetti perdurano ancora), ma anche di ricattare i governi con lo spauracchio di far mancare i cosiddetti “investimenti” in mancanza di facilitazioni e/o garanzie o in caso di politiche socioeconomiche non gradite (vedi il caso Grecia).
Per questo rimane la logica mentale (il meme) e spaziale degli stati, della “territorial trap” (Agnew, 1998) che ingabbia il pensiero comune e quello geopolitico nel riferirsi allo stato, con caratteristiche vestfaliane (territorio con confini fissi e riconosciuti), come unico perno/soggetto/attore necessario della politica e delle Relazioni Internazionali; quella logica che sostiene idealmente chi condivide l’affermazione che buone recinzioni fanno buoni vicini.
Dalla piramide al piano: con o senza recinzioni
Buone recinzioni non fanno dei buoni vicini. Tra buoni vicini ci posso essere delle recinzioni, ma anche no. E tra cattivi vicini non c’è recinzione che tenga, nel tempo e nella pratica: vedi le centinaia di tunnel scavati a Gaza, il lancio di razzi da parte di miliziani e le ripetute operazioni militari israeliane (2008-09, 2012, 2014, 2021, 2023).
La nostra attenzione deve essere puntata su come e di cosa sono fatte le recinzioni e sugli elementi fisici (comprese le condizioni di vita di base degli esseri umani che vi vivono) che differenziano il territorio ai due lati della recinzione; e questo vale anche senza recinzioni. E i segni della differenza sono le manifestazioni fisiche del potere presenti nello spazio fisico da una parte e dall’altra (e in come è fatta la recinzione e chi la controlla), perché esercitare il potere dà soddisfazione e gli esseri umani spesso non resistono a mostrarlo. E’ in questo che si vede se i vicini sono “buoni”.
Gli esseri umani, singolarmente e collettivamente, sono allo stesso tempo vittime e protagonisti del continuo processo di caging (più iconografico e connesso al potere) e di selfcaging (più soggettivo e individuale, fattore sia iconografico che di movimento). L’azione indipendente e difficilmente controllabile dei memi svolge la funzione di circolazione e favorisce sia l’irrigidimento che la composizione, scomposizione, ricomposizione dei gruppi umani nelle società, costituendo forse il carburante principale dei meccanismi “immaginari” che (tras)formano le isole culturali e le derive culturali.
Questa dinamica continua si mostra e si cristallizza nello spazio fisico ed è lì che deve puntare l’osservazione attenta del geografo. In particolare del geopolitico, che analizza le stesse dinamiche anche sotto la forma di quelle piramidi socioeconomiche che sono gli stati o qualsivoglia altra struttura di potere dichiarata formalmente e/o riconosciuta socialmente.
Magari con l’aspirazione soggettiva di contribuire ai processi di risoluzione/gestione della conflittualità umana.
Tra esseri umani liberi, uguali non solo formalmente, solidali, soddisfatti nelle esigenze di base della vita, la negoziazione è più facile e meno conflittuale e la questione recinzioni perde di rilevanza e diventa solo un gusto personale o una utilità pratica.
I processi di pace hanno successo se incidono sullo spazio fisico in modo equilibrante (cioè livellano le piramidi), fronteggiano i memi culturali (quando diventano Iconografie) e i processi di caging e selfcaging per limitarne la portata, danno tempo agli esseri umani come singoli e come gruppi di essere parti consapevoli nella dinamica tra iconografia e movimento/deriva.
Quando attivano nello spazio fisico il comune senso di appartenenza alla condizione umana, per “costruire reti al posto di piramidi” (Ward, 1976). Reti come intrecci di libertà e non come strumenti di prigionia o separazione.
Bibliografia
Agnew J., Geopolitics. Re-visioning world politics, Routledge, London-New York, 1998.
Augé M., Che fine ha fatto il futuro? Dai non-luoghi al nontempo, elèuthera, Milano, 2009.
Bertolo A., “Potere, autorità, dominio: una proposta di definizione”, in Volontà, n. 2, 1983, ripubblicato in Libertaria, Milano, anno 11, n.3, lug-sett 2009.
Boni S., Culture e poteri. Un approccio antropologico, elèuthera, Milano 2001.
Cavalli Sforza L. e F., Chi siamo, Oscar Mondadori, Milano, 1993.
Cavalli Sforza L., Menozzi P., Piazza A., The History and Geography of Human Genes, Princeton University Press, Princeton (N.J.), [trad ital. Storia e Geografia dei Geni Umani, Adelphi, Milano, 1997, p.191]
Cavalli Sforza L., L’evoluzione della cultura, Codice Edizioni, Torino, 2010.
Colombo G., (2023), Anti-Costituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società, Garzanti, Milano,
Dawkins R., Il gene egoista, Mondadori, Milano, 1995 (Ed. orig. The Selfish Gene, Revised edition 1989).
dell’Agnese E., Geografia politica critica, Guerini, Milano, 2005, p.148.
Eva F., “Global Stability through Inequality or Peace Processes through Equality”, in Special Issue of Geopolitics ‘Geopolitics at the end of the Twentieth Century: the Changing Word Political Map’, Vol 4 (1), Summer 1999, Frank Cass Publishers, London, UK, pp.98-117.
Eva F., “Cina a Giappone oggi: e domani?”, in Nuova geografia delle macroregioni, a cura di M. Fumagalli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009, pp.279-294
Eva F., “Caging/self-caging: Materiality and Memes as Tools for Geopolitical Analysis”, in Human Geography, Vol. 5, n. 3, Nov. 2012.
Farinelli F., Geografia, Einaudi, Torino, 2003.
Farinelli F., La crisi della ragione cartografica, Einaudi, Torino, 2009.
Feyerabend P., Contro il metodo, Feltrinelli, Milano, 2002, p.155.
Foucault M., “Space, Knowledge and Power (conversation with P. Rabinow)”, Skyline, March 1982, pp.16-20, pubblicato in Spazi Altri, a cura di Salvo Vaccaro, Mimesis, Milano, 2001, p. 68.
Foucault M., “Des espaces autres”, Architecture, Mouvement, Continuité, n. 5, Octobre 1984, pp.46-49, pubblicato in Spazi Altri, a cura di Salvo Vaccaro, Mimesis, Milano, 2001, p. 24.
Foucault M., Storia della sessualità. La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano, 2001, pp.125-126.
Galli C., Spazi politici, il Mulino Saggi, Bologna, 2001, p. 12.
Galullo R., Economia criminale, Il Sole 24 ore, Milano, 2010.
Garcia V., intervento al seminario internazionale “Anarchismo, post-anarchismo e neo-anarchismo nel ventunesimo secolo”, 4-5 luglio 2009, Venezia-Marghera, pubblicata nel numero speciale del Bollettino del Centro Studi Libertari-Archivio G.Pinelli, Milano, n.34, dicembre 2009, p.14.
Giles J., “Come si diffonde una bugia”, New Scientist, GB, tradotto in Internazionale, Roma, anno 17, n.856, 23/29 luglio 2010, p.52.
Godwin W., “An account of the Seminary that Will Be Opened on Monday the Fourth Day of August, at Epsom in Surrey, for the Instruction of Twelve Pupils in the Greek, Latin, French and English Languages”, in Morning Herald &Daily Advertiser, July 2nd 1783.
Goodway D., Conversazioni con Colin Ward, Eleuthera, Milano, 2003.
Gottmann J., La politique des Etats e leur géographie, Colin, Paris, 1952.
Lèvi Strauss C., Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Milano, 1978.
Monod J., Il caso e la necessità, Mondadori, Milano, 1970
Newman D., “Shared spaces-Separated spaces: Israel-Palestine peace process”, Geojournal, 39:4, Kluwer Academic Publisher, Netherland, pp.364-375, 1996.
Newman S., From Bakunin to Lacan: Anti-Authoritarism and Dislocation of Power, Lexington Books, Lanham, 2001.
Pancera C. (a cura di), William Godwin. Sull’educazione e altri scritti, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze), 1992.
Rawls J., Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano, 1982 (Ed. orig. A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971).
Reclus E., L’Homme et la Terre, Librairie Universelle, Paris, 1905-1908.
Scevola N., “Do you speak Shugni?”, in Io Donna, supplemento del Corriere della Sera, 7 luglio 2010, pp. 29-32.
Stiglitz J., La globalizzazione che funziona, Einaudi, Torino, 2006, p. 157
Taylor P.J., “A materialistic framework for political geography”, Transactions of the Institute of British Geographers, NS, 1, pp.129-142, 1982.
Toal G., Critical Geopolitics, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, p.94.
Vaccaro S., “Attenzione, spia accesa”, nel numero speciale del Bollettino del Centro Studi Libertari-Archivio G.Pinelli, Milano, n.34, dicembre 2009, p.5.
Yiftachel, O., ‘Between Colonialism and Ethnocracy: ‘Creeping Apartheid in Israel/Palestine’, in Jeenah, N. (ed), Pretending Democracy: Israel, an Ethnocratic State, African Middle East Centre, Johannesburg, 2012, pp. 95-116.
Ward C., Anarchia come organizzazione, Antistato, Milano, 1976 e ried. Elèuthera 2006).
Weisman A., Il mondo senza di noi, Einaudi, Torino, 2008.
Weizman E., Architettura dell’occupazione, Bruno Mondadori, Milano, 2009.